Il cappello
###Per non dimenticare
Era fine estate, il quindicesimo giorno di settembre del 2018. Un sabato. Nella mia amata città natale non solo si parlava di ciò che era accaduto molti decenni prima in autunno, in piena Seconda guerra mondiale, ma era già tutto pronto per la commemorazione. Ci sono stata con l’amica veronese Francesca Pasetto, sensibile “Virgilio” capace con disinvoltura di farmi dimenticare i gli ostacoli della mia tribolata vista di ipovedente a cui mi ha costretta la violenza di una subdola malasanità ed è stata una giornata speciale nella quale siamo stati in compagnia di mia mamma Elide Malagutti che ora ha 92 anni e del suo genitore, il nonno Luigi, mi ha raccontato; “Non eravamo ebrei ma avversi alle camicie nere e per sfuggire a chi cercava la gente per picchiarla e far bere l’olio di ricino, “miè popà” è stato due giorni e due notti senza muoversi nascosti in un fosso. Io ero piccola e quando andavo in città con lui, si faceva tappa fissa da sua sorella che abitava dalle parti di via Saraceno, in una vietta interna, e ascoltare Radio Londra. Sento ancora i battiti di quando iniziava”.
Sono riuscita a scrivere svariati articoli sull’eccidio del castello estense, tra cui La Muova Ferrara, ed anche sul quotidiano L’Arena di Verona, città dove vivo e lavoro allo storico giornale. Fatalità proprio da Verona è partito l’ordine di rappresaglia del gerarca fascista Alessandro Pavolni che vi si trovava per il Congresso del Partito Fascista repubblicano e aveva ricevuto la notizia dell’assassinio in un agguato di Igino Ghisellini, federale di Ferrara.
Rivivo anche quest’anno, nel 2024 e lo farò sempre finché avrò fiato, la ricorrenza del 15 novembre 1943, quella dell’eccidio del Castello Estrnse che mio papà Oberdan Pezzani, classe 1928, mi ha raccontato fin da bambina. Lui c’era; poco più di un adolescente, 16 anni, ma ragazzo già maturo nella vita e in famiglia.
La Storia ha incontrato la gente in Corso Martiri della Libertà, ex Corso Roma, a Ferrara, di fianco al Castello Estense quel 15 settembre 2018 in memoria del 15 novembre 1943, giorno del calendario che nella cabala ebraica significa gloria.
A dieci anni dalla scomparsa del regista di origine estense Florestano Vancini(1926-2008) il suo film «La lunga notte del '43» girato nel 1960 e in quell'anno premiato come opera prima al Festival del Cinema di Venezia, è stato proiettato gratuitamente su maxi schermo sul luogo del dramma. Quattrocento i posti a sedere. L'evento è stato organizzato dall'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara in collaborazione con il Comune e il sostegno economico del comitato Bassani, con ospite d'onore Gloria Vancini, figlia del regista che raccontò "amore e guerra" in quella pellicola dal cast singolare (Enrico Maria Salerno, Gino Cervi, Gabriele Ferzetti, Belinda Lee, Andrea Checchi, Raffaella "Carrà" Pelloni): punto focale della trama l'eccidio per mano fascista avvenuto ai piedi del baluardo, di inermi cittadini ebree e non avversi alla dittatura, colto nel drammatico segno dalla nebbiosa fotografia di Carlo Di Palma, sottolineata dalle musiche di Carlo Rustichelli.
Significativa è stato inoltre nella realizzazione del film cult il rifiuto di Vancini nei confronti produttore Dino De Laurentiis di inserire attori stranieri. La sceneggiatura originale donata da Vancini nel 1993 all'Istituo di Storia contemporanea di Ferrara, è tratta dal racconto «Una notte del '43» di Giorgio Bassani, anch'egli "frarés doc" di cui è ricorso oltretutto il centenario della nascita.
Per l'occasione dell'attesissina serata di "cinema all'aperto" il copione scritto da Vancini insieme ad Ennio De Concini e Pier Paolo Pasolini, ha visto nuova stampa pubblicata da La Carmelina, su iniziativa dell'Istituto di Storia Contemporanea, a cura per l'editing degli storici Angela Ghinato e Nicoló Govoni, valenti ricercatori ferraresi.
«Il lungometraggio riporta un evento, esempio conosciuto di guerra civile perché sono fascisti italiani a compiere una vendetta su italiani, che ha segnato sia Ferrara sia il Paese intero e che colpì profondamente lo stesso Vancini all'epoca dei fatti liceale diciassettenne», ha ricordato Anna Maria Quarzi, «Realizzato dal regista con grande difficoltà soltanto nel Sessanta, il film riesce ad incrociare tre sguardi diversi: l'avvenimento storico, lo sguardo del regista e lo sguardo del regista testimone di quei giorni».
Ritorno non spesso come vorrei a Ferrara perché mi è difficile trovare facilmente qualcuno che mi accompagna ma riesco, seppur poco, ad andare a trovare mia mamma.
E quando nel corso del temposono stata anche più volte l’anno nella città di pianura a incontrare chi ora non c’è più, mi hanno toccato nel profondo le testimonianze a viva voce di ciò che la memoria non può cancellare avendo visto, quando si compì “l’eccidio del muretto del Castello estense”. Ne parlavo proprio ieri sera al telefono con l’amica Maria Cristina Piccoli, ferrarese come me, spugne della memoria della mostro comune mondo mai perduto nonostante lei sia diventata cieca seppure provvista del terzo occhio.
Una mostra immortala quei terribili istanti. Ne rende perenne la presenza e anche quest’anno, all’aperto, rompe il silenzio. Si intitola “Per non dimenticare” ed è stata allestita sul luogo della tragedia: si tratta di sagome a dimensione umana raffiguranti le vittime di quella che fu una rappresaglia fascista per vendicare l’uccisione avvenuta tra Casumaro e Ferrara, del federale di Ferrara Camerata Igino Ghisellini. La mostra è di forte impatto, corredata da testi e immagini divulgative circa ogni vittima ed è realizzata dal Comune di Ferrara in collaborazione con l’istituto di Storia contemporanea, curata da Anna Maria Quarzi, in collaborazione con Giulia Aguzzoni, con allestimento dello Studio Sigfrido.
Già dalle ore venti del 14 novembre 1943 erano arrivate le squadracce a Ferrara da Verona su ordine del gerarca Alessandro Pavolini che lì si trovava per il Congresso del Partito fascista repubblicano, e in poche ore si effettuarono le retate: 73 furono gli arrestati condotti nella caserma Littorio situata in Piazza Fausto Beretta e tra quegli arrestati c’era anche la maestra Alda Costa, figura di spicco dell’antifascismo. Nel carcere di via Piangipane erano già stati imprigionati altri 34 tra oppositori del regime, ebrei, antifascisti e fra tutti, senza un criterio preciso ne furono scelti 10 da passare alle armi, appunto all’alba, affinché tutti i ferraresi al risveglio li vedessero, a monito. Solo l’Arcivescovo Ruggero Bovelli, con severa recriminazione alle autorità fasciste, riuscì a far poi spostare i corpi.
Si chiamano Emilio Arlotti, Pasquale Colagrande, Mario e Vittore Hanau, Giulio Piazzi, Ugo Teglio, Alberto Vita Finzi, Mario Zanatta; sulle mura nei pressi di
Rampari di San Giorgio Gerolamo Savonuzzi e Arturo Torboli; infine il giovane ferroviere Cinzio Belletti, che tornando dal lavoro aveva assistito alla strage e venne inseguito e assassinato in via Boldini.
Secondo lo storico Claudio Pavone quello del 15 novembre 1943 può essere considerato come il primo eccidio di guerra civile in Italia.
Così scrisse Giorgio Bassani nel celebre resoconto:
“Erano undici: riversi, in tre mucchi lungo la spalletta della Fossa del Castello, lungo il tratto di marciapiede esattamente opposto al caffè della Borsa e alla farmacia Barilari: e per contarli e identificarli, da parte dei primi che avevano osato accostarsi (di lontano, non parevano nemmeno corpi umani: stracci, bensì, poveri stracci o fagotti, buttati là, al sole, nella neve fradicia), era stato necessario rivoltare sulla schiena coloro che giacevano bocconi, nonché separare l’uno dall’altro quelli che, caduti na coloro che giacevano bocconi, nonché separare l’uno dall’altro quelli che, caduti, abbracciandosi, facevano tuttora uno stretto viluppo di membra irrigidite».
Così disse il testimone oculare Oberdan Pezzani, mio papà, che all’età di 16 anni stava andando a scuola all’Istituto Vincenzo Monti dove frequentava Ragioneria e giunto alla fine di Via della Giovecca si era avvicinato sgomento alla carneficina dopo essere sceso dalla bicicletta:
“La scena è sempre nitida in me di quei martiri. E persino di quel cappello volato poco distante dai corpi di un uomo anziano e di suoi figlio che si tenevano a braccetto e così erano caduti. Tutti e due col cappotto. Seppi poi chi fossero da mio padre che li conosceva. Gli Hanau, di religione ebraica, papà e figlio, commercianti di pellami che avevano la centralissima bottega in via Canonica”.
Un dettaglio struggente quello del capello, sembrerebbe una lobbia o un Borsalino, che nel preciso fotogramma del film di Vancini grida. Muto.




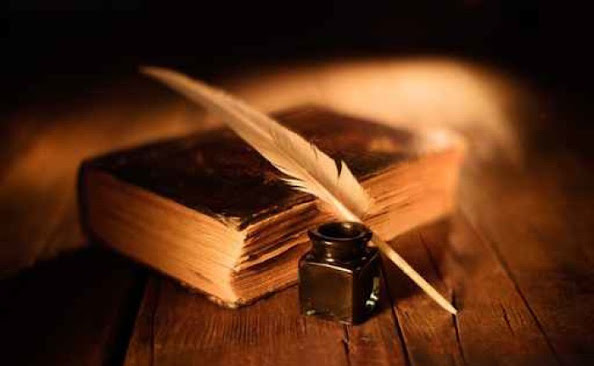

Commenti
Posta un commento